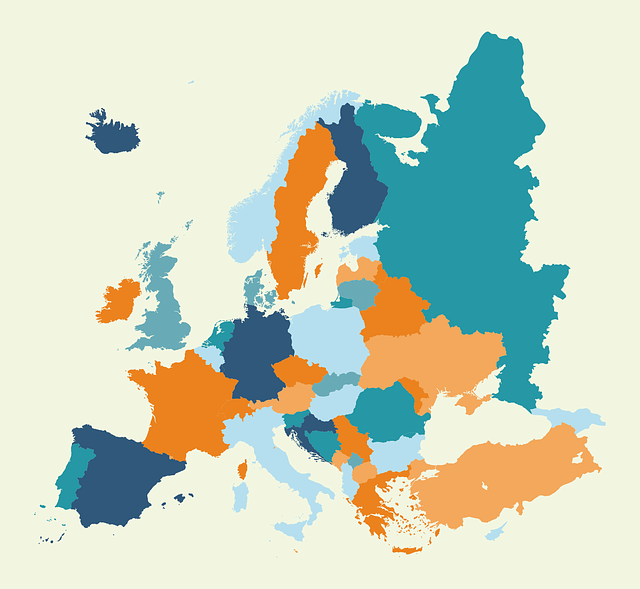
La Meglio Gioventù. BleDar Hasko, dall’Albania in Italia. “Bisogna Puntare sulle differenze, simbolo di civiltà”
Tappeti di carne in movimento, sopra navi mercantili, distribuzione di viveri, «voglio andare in Italia» «non siamo cani» saluti avvolti dentro cappotti d’emergenza, donne che guardano in telecamera, famiglie intere, «grazie Italia», «Dio mio aiuto» bambini avvolti in fasce, professori, contadini, operai, disgraziati senza niente sulle spalle, «amiamo molto il nostro paese ma il governo ci ha trattato male» corpi si gettano in acqua, «ringrazio il popolo italiano e il governo italiano per il grande spirito e il grande cuore, ringrazio anche la mia famiglia che spero mi guarda in televisione» All’indomani della caduta del Muro di Berlino, l’Italia scoprì di essere l’America. Dal porto di Durazzo, arrivarono a migliaia sulle coste italiane, grazie a navi come la Vlora. Era il 1991. L’Albania veniva lasciata dai suoi figli. Le conseguenze della fine del Comunismo – così com’era conosciuto fino a quel momento – portarono all’innesco di meccanismi sociali devastanti: guerre civili e fenomeni migratori. Oggi, dall’Africa e dal Medio Oriente, accade lo stesso. Noi italiani ed europei continuiamo a parlarne come se fosse un fenomeno che non ci appartiene. Ma qui scadremmo in banali, seppur amare, considerazioni. Migrare è conseguenza dei tempi umani, di ogni tempo. Migrazione è botola della necessità. Secondo il sociologo polacco, Zygmunt Bauman il fenomeno migratorio riguarda la modernità, «perché la modernità produce “persone inutili”», disse in un’intervista rilasciata a “L’Espresso”. «Esistono due “industrie” della modernità che producono “persone inutili” – spiegò lo studioso – una è quella così detta della “costruzione dell’ordine”, dove ogni regola e sistema vengono costantemente rimpiazzati da nuovi sistemi e regole che producono esuberi, persone eccedenti. L’altra industria che produce “persone inutili” è quell’industria che noi chiamiamo “progresso economico” che consiste, fondamentalmente, nel ridurre costantemente la forza lavoro. E questo semplicemente produce persone inutili. E queste persone andranno dove c’è pane, promesse di pane e acqua potabile». C’è chi parlava di inevitabilità e ineluttabilità, come il compianto Umberto Eco secondo il quale «il Terzo Mondo sta bussando alle porte dell’Europa, e vi entra anche se l’Europa non è d’accordo. Il problema non è più di decidere (come i politici fanno finta di credere) se si ammetteranno a Parigi studentesse con il chador o quante moschee si debbano erigere a Roma. Il problema è che nel prossimo millennio (e siccome non sono un profeta non so specificare la data) l’Europa sarà un continente multirazziale». Pochi parlano di opportunità delle differenze e, dunque, di occasione necessaria per la costruzione di una futura civiltà. Ecco perché lo sguardo di Bledar Hasko diventa preziosa testimonianza, in questa analisi storico-sociale. Reporter freelance per il “Corriere del Mezzogiorno”, “Il Manifesto”, “Osservatorio Balcani e Caucaso”, fotografo, videomaker, giornalista. Un giovane albanese, partito a 18 anni dal suo paese, per venire a studiare in Italia. Qui, nella terra che scoprì di essere l’America, Bledar ha proiettato dinanzi a sé un nuovo sguardo, raccontando i nostri tempi. Ultimamente è stato a Idomeni, il piccolo villaggio del Comune di Paionia, dove si rifugiano migliaia di persone provenienti da Siria, Pakistan, Afghanistan, allo scopo di attraversare il confine greco ed entrare nella Repubblica di Macedonia per giungere, immettendosi sulla rotta balcanica, nei paesi del Nord Europa.
Perché hai scelto l’Italia?
«Sentivo un’empatia per la cultura italiana. Quando nella mia città, Argirocastro, si parlava di punti riferimento, si nominava sempre la Francia, mentre io pensavo all’Italia. Ho imparato l’italiano in terza elementare. Nei primi anni ‘90, la prima lingua straniera era l’italiano, per questioni legate all’immigrazione, oppure il greco. Appartenevo a una delle prime generazioni che studiava all’estero. Ho scelto una città a misura d’uomo: Salerno. In Albania, ho conosciuto un gruppo di italiani che erano venuti con la Caritas. Mi regalarono un marsupio con la scritta “Salerno”. Quando, 18enne, decisi con mio padre di venire in Italia, controllammo sulla mappa. Non c’era ancora internet. Arrivai in Italia nel 2001. Ero orientato al Sud Italia e cercavo una città piccola. Il campus salernitano già all’epoca era ben organizzato e sempre in espansione. Mi iscrissi a economia. Dopo la prima lezione, capii che avevo sbagliato facoltà. Così ho fatto un esame solo. Decisi di iscrivermi a Lettere e filosofia».
È stata dura all’inizio?
«Il desiderio dei miei genitori era di farmi avere una cultura alta ed europea. Hanno venduto la casa in cui ero cresciuto, per mantenermi in Italia, e sono andati a vivere in affitto. Me la sono dovuta guadagnare la loro fiducia. Hanno premiato la mia passione per la letteratura. All’epoca, alloggiavo all’hotel K di Pastena. Iniziarono a scarseggiare i soldi e così andai per una settimana nel dormitorio della Caritas di via Bottiglieri. Era aperto solo la notte e tutto il giorno dovevo stare fuori. Mi perdevo tra le strade di Salerno. Non riuscivo a orientarmi. Poi trovai alloggio all’ostello della gioventù di via Luigi Guercio. Qui trovai un ambiente bellissimo. La maggior parte stranieri. C’erano circa 40 senegalesi che vivevano in maniera autonoma e si autogestivano. Nell’altra parte della struttura, c’erano gli ucraini. Parlavo un italiano senza accento, sembrava una lingua ancora in modulazione col posto. Legai molto con Mauro Francolini, che oltre a gestire l’ostello faceva anche i turni di notte. Mi ricordo lui dietro il computer, quest’omone grosso e dolcissimo, faceva diverse attività contemporaneamente. Quando mostravo i documenti per cercare casa e fare un contratto, i proprietari anziani delle abitazioni mi dicevano che la stanza era stata già occupata. Mauro si rese conto della difficoltà e, con sua moglie Antonella, mi invitò a casa per stare un periodo con loro. Dopo circa 5 mesi – nel frattempo avevo conosciuto loro figlio Marcello, con cui ho legato subito – riuscii a trovare casa proprio qui, a via Luigi Guercio. Ascoltavo i 99 Posse, 24 Grana, gli Almamegretta, e accentuai il mio dialetto del posto. Frequentavo l’asilo politico e il laboratorio Diana. Ebbi contatti anche con il laboratorio studentesco. Quando mi trovai in difficoltà di nuovo, Antonella e Mauro mi ospitarono ancora. Il giorno di Natale del 2003, Mauro mi disse che avrebbe voluto che rimanessi con la loro famiglia finché non avessi finito gli studi».
Quando hai lasciato l’Albania, cosa hai provato?
«Me ne sono andato con amore, non l’ho mai odiato il mio paese. Questo mi ha aiutato, perché ho capito che non rinnegavo la mia terra e, dall’altra parte, non mi sono chiuso all’interno di un “cerchio” albanese a Salerno. Ora come ora, non sono né italiano né albanese. Posso esser le due cose allo stesso tempo. Sono un ibrido. Dentro di me c’è una grande contraddizione e, come ogni conflitto, è qualcosa di molto fertile. Ho puntato sempre sulle differenze mai sull’uguaglianza. Ho sempre fatto il ragionamento di capire dov’è che sono diverso da un italiano e dove un italiano è diverso da me. Questo punto di vista mi dà la possibilità di esercitare un occhio critico nei confronti del posto in cui vivo».
Dunque, cosa significano uguaglianza e parità?
«Uguale è una parola che dà scontate troppe cose. La parola uguaglianza è un retaggio dei sistemi totalitaristici. Siamo una società massificata, all’interno del consumismo. L’individuo, quindi, non può fare un discorso di uguaglianza ma di diversità. Al massimo, si dovrebbe sostituire la parola uguaglianza con la parola parità».
E il fenomeno migratorio?
«Dobbiamo fare un’analisi in termini economici. L’Europa oggi non ragiona più sul piano politico, ma di espansionismo. Le stesse primavere arabe sono state fomentate da un discorso economico, al di là dell’opposizione contro i regimi totalitari. Noi occidentali siamo presuntuosi, pensiamo di esportare il nostro sistema di vita a civiltà che sono totalmente diverse, impiantate su altri valori, un’altra storia. Non puoi cancellare tradizioni millenarie da un giorno all’altro. Qui ritorna il discorso sul rispetto delle differenze. L’immigrazione è sempre esistita e sempre esisterà lo spostamento di un popolo verso terre più ricche. Fondamentalmente, noi occidentali, dobbiamo il benessere grazie allo sfruttamento del Terzo mondo. C’è una distribuzione mondiale del benessere totalmente sbilanciata e l’Occidente non è neanche un quarto della popolazione mondiale. Per quanto riguarda questo periodo storico, ci sono persone che scappano dalla guerra civile, la guerra più brutta che si possa vivere. Mi rendo conto che la maggior parte di chi viene in Europa, anche nel campo di Idomeni dove sono stato, non vuole strapparci il benessere. Si pensa che vogliano fregarci il lavoro. In realtà è gente che non ha più dove tornare».
Parlami di Idomeni…
«Mi hanno chiamato insieme a Michele Amoruso e Ivan Romano, due fotoreporter salernitani, di Postiglione e Pontecagnano. Mi ero informato sulla rotta balcanica e aspettavo che i migranti passassero per l’Albania. Avevo deciso di partire nel momento in cui il flusso si fosse diretto lì. Consapevole che mi sarei imbarcato in una missione delicata ed emotivamente forte. Infatti, quando sono arrivato in tarda mattinata a Idomeni, in Grecia, le mie aspettative sono state distrutte. Era ancora peggio di quello che mi aspettavo. Un campo di grano occupato dalle tende, fango, i recinti per fare le file per i documenti, le visite mediche, il cibo. Idomeni è un campo spontaneo, presso il confine greco-macedone, nella provincia del Kilkis. Persone che passano il confine dalla Turchia e si trovano in un confine di trafficanti. Con questi arrivano sulle isole greche, di fronte alle coste occidentali turche. Passano anche da Istanbul. Da lì le autorità greche, una volta passati per gli hotspot, prendono questi uomini e donne e li trasferiscono al porto del Pireo per smistarli in vari centri del territorio greco. Ma la gente, in questi centri, non ci vuole stare e scappa verso la rotta del confine greco-macedone. A Idomeni c’erano 10500 rifugiati.
Di questi, il 36% erano bambini e di questa percentuale il 10% erano bambini senza genitori, cioè bambini dispersi, che andavano a finire nel traffico d’organi. Idomeni è un tappo europeo, costruito da paesi che non vogliono che i migranti arrivino nei propri territori. È un monito, con cui l’Europa sta dicendo “qui non si passa”».
Quanto tempo sei rimasto lì?
«Sei giorni. Ci alzavamo all’alba, dalle 4 alle 8. Poi tornavamo in albergo per inviare le foto e i pezzi e rielaborare le interviste in inglese. Si ritornava al campo verso le 11. A Idomeni ho toccato con mano la solidarietà del popolo greco. La Grecia vive un periodo difficile ed è singolare il fatto che uno dei paesi a cui l’Europa deve, insieme all’Italia, i concetti di libertà, di democrazia, di cultura, di fondazione, sia anche la terra che sta peggio nella Comunità Europea. I poliziotti greci non avevano neanche il diesel da mettere nei pullman. Nel campo vedevi professionisti in tenda. In cosa ero diverso da loro? Io avevo una casa in cui tornare. La crisi siriana ha prodotto la crisi di profughi più grande dagli anni ’90 a oggi. In Siria vivono milioni sotto i bombardamenti. Ci sono 13 milioni di persone che stanno aspettando di riversarsi nelle nostre città. Come se ne esce da questa situazione? Il problema è che noi dimentichiamo ciò che siamo stati. Questi bambini, un giorno ricorderanno quello che hanno passato. A Idomeni le condizioni igienico-sanitarie sono inesistenti. Arrangiano con tutto. Per riscaldarsi bruciavano plastica, legna, respirando fumi velenosi. Poi il freddo, il fango. Quando camminavi tra le tende, c’era il pianto dei bambini e poi la tosse».
Possibile l’integrazione?
«È una parola molto retorica. Credo che più che integrazione, bisogna parlare di convivenza. Integrare indica qualcosa di incompiuto. Bisogna convivere ed essere capaci di accettarsi. Naturalmente una persona che va in un altro paese deve capire quali sono le differenze e i diritti e doveri. Io che ho avuto la fortuna di venire in Italia per studiare, non ho scelto né la via dell’integrazione né del rinnegamento, ma dell’ibrido. Allargare la mia famiglia albanese, una famiglia mediterranea, avere un fratello italiano, due paia di genitori, una sorella albanese».
Ti stai occupando del progetto Schiapoli. Cos’è?
«L’umanità non si è mai liberata dal concetto di schiavitù. Schiapoli, perché queste persone – che chiamiamo migranti, clandestini, irregolari e li guardiamo sempre in televisione, attraverso le immagini, gli schermi – in realtà non sono nulla di questo. Sono “schiapoli”, cioè in condizioni di schiavi e apolidi, ormai non appartengono più a nessun luogo o meglio appartengono a un non luogo, Idomeni, dove si nega anche la fisicità del corpo umano. Schiapoli è una parola formulata da Mauro Francolini e sarà una parola del prossimo futuro».
Davide Speranza
